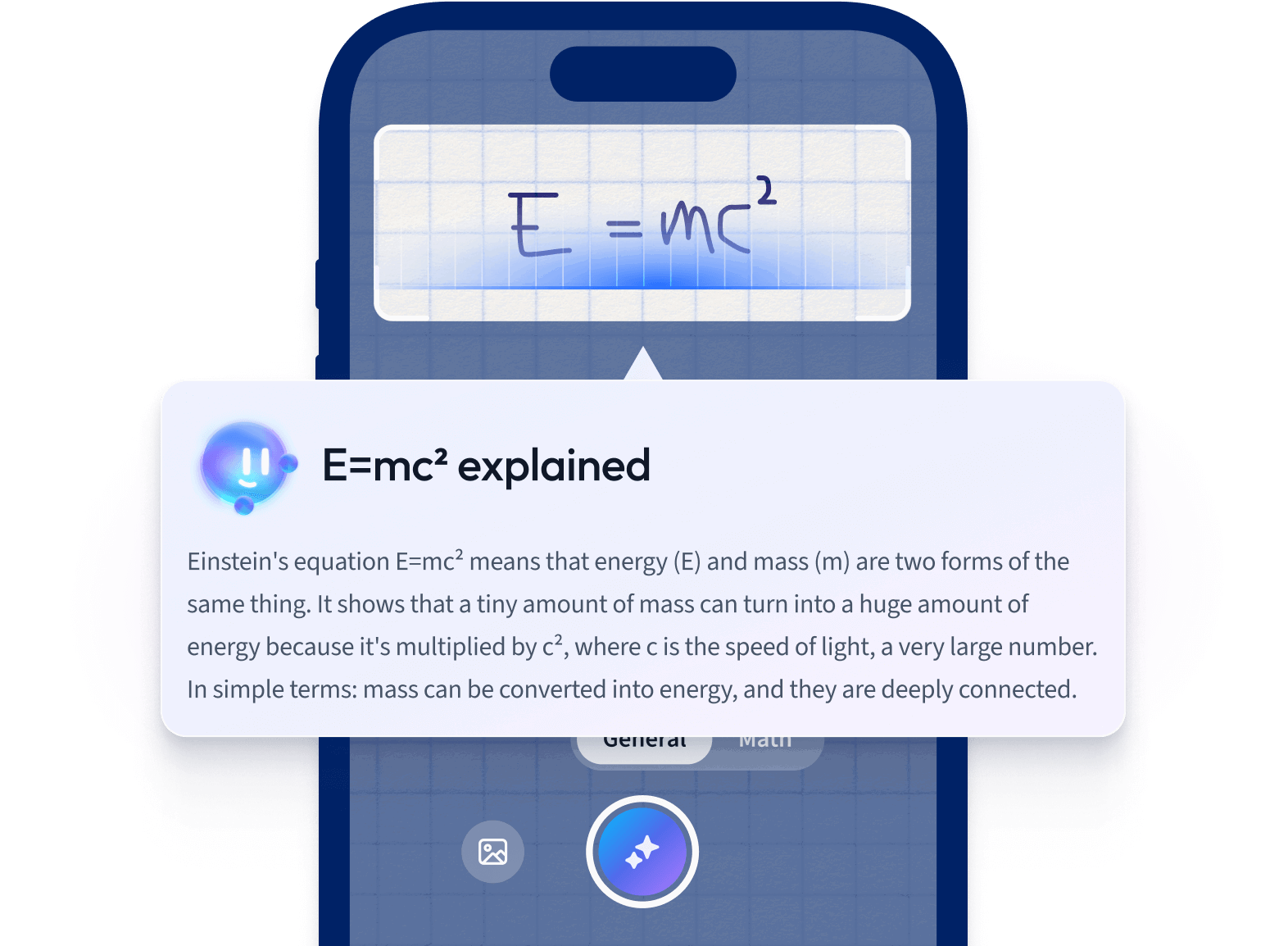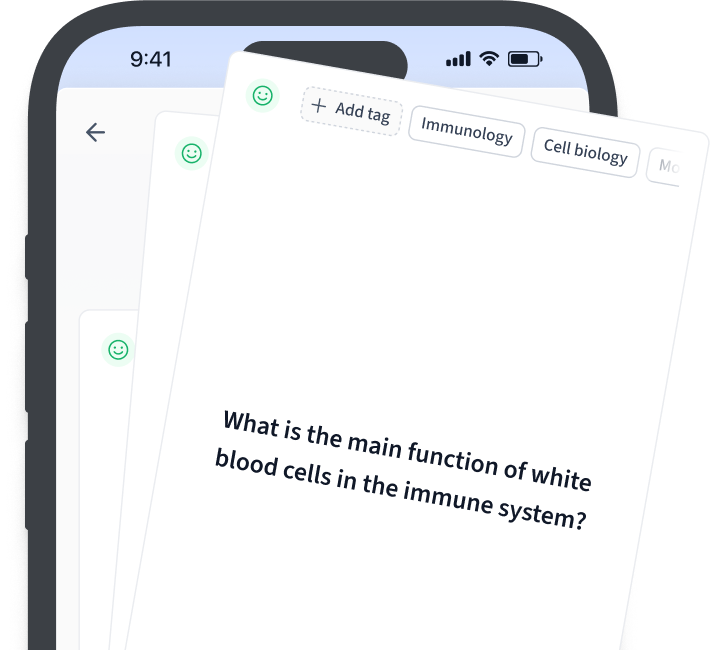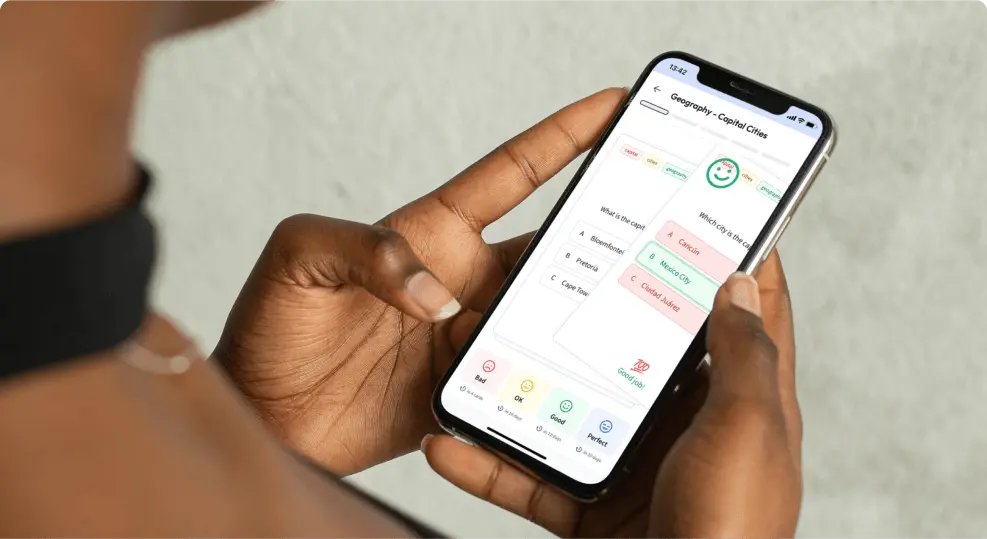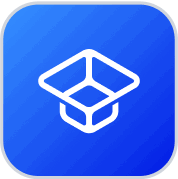Ora immagina di fare lo stesso puzzle con metà dei pezzi mancanti e senza un'immagine finita che vi aiuti. È quello che devono aver provato i chimici quando hanno cercato di organizzare tutti gli elementi in quella che oggi conosciamo come tavola periodica.
- Analizzeremo la tavola periodica in chimica fisica.
- Inizieremo con la definizione della tavola periodica, prima di vedere come è strutturata.
- Esploreremo poi la sua storia.
- Alla fine di questo articolo, dovresti essere in grado di spiegare come è strutturata la tavola periodica, di confrontare righe, colonne e blocchi della tavola periodica e di descrivere come la tavola periodica è cambiata nel tempo.
- Alla fine di questo articolo, dovresti essere in grado di spiegare come è strutturata la tavola periodica, di confrontare righe, colonne e blocchi della tavola periodica e di descrivere come la tavola periodica è cambiata nel tempo.
Tavola periodica degli elementi
Ecco la definizione di tavola periodica:
La tavola periodica è una rappresentazione degli elementi ordinati in base al loro numero atomico.
 Figura 1. La tavola periodica.
Figura 1. La tavola periodica.
La tavola periodica è utile perché ordina gli elementi in righe e colonne in base alle loro proprietà. Ciò significa che, una volta nota la posizione di un elemento nella tavola periodica, è possibile prevedere il suo comportamento e le sue reazioni. Cominciamo a vedere la sua struttura.
Tavola periodica spiegazione
Innanzitutto, la tavola periodica è composta da elementi. Questi elementi sono assemblati in righe, colonne e blocchi. Non è sempre stato così, ma approfondiremo come è cambiata più avanti, quando parleremo della storia della tavola periodica. Per ora, ci addentreremo nei modi in cui è strutturata la tavola periodica.Elementi
Come abbiamo definito in precedenza, la tavola periodica è una disposizione di elementi. Ricordiamo che un elemento è una sostanza chimica pura costituita da atomi che hanno tutti lo stesso numero di protoni nel nucleo. Il numero esatto di protoni determina il numero di elettroni; è questo che rende un elemento, beh, un elemento!
Gli elementi della tavola periodica sono indicati con il loro simbolo chimico. Si tratta di un'abbreviazione di una o due lettere, unica per ogni elemento. La prima lettera è sempre maiuscola, mentre la seconda è minuscola. Ad esempio, il rame è noto come Cu, il calcio come Ca e il carbonio come C. Gli elementi sono indicati anche con il loro numero atomico e la massa atomica relativa.
Il numero atomico di un elemento è il numero di protoni presenti nel suo nucleo, mentre la massa atomica relativa è la massa media di un atomo dell'elemento. Si tratta della massa dei protoni e dei neutroni presenti nel nucleo dell'atomo. La massa atomica relativa è misurata su una scala particolare, dove un atomo di carbonio-12 ha una massa esattamente pari a 12.
 Figura 2. Un elemento. Il litio.
Figura 2. Un elemento. Il litio.
Per saperne di più sulla massa atomica relativa, visita Spettrometria di massa. Per saperne di più su come i protoni e gli elettroni di un atomo influenzano le sue proprietà, consulta la sezione Particelle fondamentali.
Periodi
Uno dei modi in cui gli elementi sono assemblati nella tavola periodica è in righe. Una riga nella tavola periodica è nota come periodo; da qui deriva la parola periodico. Le righe della tavola periodica mostrano la periodicità.
La periodicità si riferisce alle tendenze che si osservano quando si attraversa un periodo (riga) della tavola periodica. Queste tendenze si ripetono a ogni nuovo periodo.
Gli elementi di un periodo sono ordinati per numero atomico crescente. Ricordate che il numero atomico è il numero di protoni di un elemento. Il numero atomico aumenta di 1 ogni volta che ci si sposta da sinistra a destra attraverso un periodo della tabella. Quando si raggiunge la fine di un periodo, ci si sposta verso il basso e a sinistra fino all'inizio di un nuovo periodo e si continua a contare i numeri atomici da lì. In totale ci sono 7 periodi nella tavola periodica.
 Figura 3. Tavola periodica. Periodi.
Figura 3. Tavola periodica. Periodi.
 Figura 4. Il numero atomico aumenta lungo un periodo.
Figura 4. Il numero atomico aumenta lungo un periodo.
Gli elementi dello stesso periodo hanno lo stesso numero di gusci di elettroni. Ad esempio, gli elementi del periodo 1 hanno un solo guscio elettronico, mentre gli elementi del periodo 5 hanno tutti cinque gusci elettronici.
Tavola periodica gruppi
Anche gli elementi della tavola periodica sono riuniti in colonne. Queste colonne sono chiamate gruppi. In totale, i gruppi della tavola periodica sono 18, con una numerazione ufficiale IUPAC da 1 a 18. Tuttavia, ai fini del corso, seguiremo il sistema di numerazione tradizionale: 1-0 o 1-8. Questi, sono solitamente mostrati in forma di numeri romani. I gruppi sono:
- Metalli alcalini (gruppo I)
Metalli alcalino-terrosi (gruppo II)
Gruppo del boro (gruppo III)
Gruppo del carbonio (gruppo IV)
Gruppo dell'azoto (o dei pnicoogeni) (gruppo V)
Gruppo dell'ossigeno (o dei calcogeni) (gruppo VI)
Gruppo degli alogeni (grouppo VII)
Gruppo dei gas nobili (grouppo VIII)
 Figura 5. Gruppi nella tavola periodica.
Figura 5. Gruppi nella tavola periodica.
Gli elementi sono raggruppati in base al numero di elettroni presenti nel loro guscio esterno. Gli elettroni del guscio esterno sono noti anche come elettroni di valenza. Gli elettroni di valenza determinano le proprietà chimiche e la reattività di un elemento. Ciò significa che gli elementi dello stesso gruppo reagiscono tutti in modo simile. Tuttavia, si noti che ogni elemento di un gruppo ha un guscio elettronico in più rispetto all'elemento che lo precede.
Gli elettroni di valenza sono gli elettroni che si trovano nel guscio esterno di un atomo.
Il vecchio sistema di numerazione è utile perché ci dà un'indicazione di quanti elettroni di valenza possiede un elemento di un determinato gruppo. Ad esempio, tutti gli elementi del gruppo I, i metalli alcalini, hanno un solo elettrone di valenza. Al contrario, tutti gli elementi del gruppo VII, gli alogeni, hanno sette elettroni di valenza. I gas nobili, del gruppo VIII, hanno tutti otto elettroni di valenza, che conferiscono loro gusci elettronici esterni completi.
Il gruppo I comprende anche l'idrogeno, anche se non è un metallo alcalino e reagisce in modo diverso dagli altri membri del gruppo. Con un numero atomico di 1, l'idrogeno è l'elemento più leggero esistente. Ha un solo protone e un solo elettrone. Ci si potrebbe quindi aspettare di trovare l'elemento successivo più leggero, l'elio, accanto nel gruppo II, poiché ha solo due protoni e due elettroni. Invece l'elio si trova nel gruppo VIII. Questo perché il guscio di valenza dell'elio ha spazio solo per due elettroni, il che significa che l'elio ha in realtà un guscio esterno completo di elettroni. Questo fa sì che si comporti come gli altri elementi del gruppo VIII.
Il numero di gruppi della tavola periodica, 18, è stato raccomandato dall'Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata (IUPAC) nel 1988. Ha sostituito il vecchio sistema di numerazione, 1-0, o 1-8 (che esclude gli elementi del blocco d e f, di cui parleremo più avanti). Il sistema più vecchio è ancora in uso comune, soprattutto nelle commissioni d'esame inglesi (AQA) e scozzesi (SQA), ed è la versione da conoscere.
Blocchi della tavola periodica
Avrai notato che utilizzando il vecchio sistema di numerazione dei gruppi si perdono due grandi porzioni della tavola periodica. Che ne è degli elementi tra il II e il III gruppo, che si trovano nei gruppi IUPAC da 3 a 12? Che ne è di quelle due file di elementi sotto la tavola periodica - dove si collocano? Un altro modo di vedere la tavola periodica è quello di dividerla in blocchi.
I blocchi della tavola periodica sono gruppi di elementi che hanno tutti l'elettrone di valenza a più alta energia nello stesso sottoguscio.
La tavola periodica è composta da quattro blocchi:
- Gli elementi del blocco s hanno tutti il loro elettrone di valenza a più alta energia in un sottogruppo s. Il blocco s comprende i gruppi I e II.
- Gli elementi del blocco p hanno tutti il loro elettrone di valenza a più alta energia in un sottogruppo p. Il blocco p comprende i gruppi dal III al VIII, o in termini IUPAC, dal 13 al 18, ed è costituito per lo più da non metalli.
- Gli elementi del blocco d hanno tutti il loro elettrone di valenza a più alta energia in un sottogruppo d. Il blocco d comprende i gruppi da 3 a 12 e comprende anche i metalli di transizione.
- Gli elementi del blocco f hanno tutti il loro elettrone di valenza a più alta energia in un sottogruppo f. Il blocco f comprende i lantanidi e gli attinidi. Si tratta delle due file mostrate sotto il corpo principale della tavola periodica. Di seguito abbiamo mostrato la loro posizione rispetto agli altri elementi della tavola periodica.
Sì, sappiamo che abbiamo detto che l'elio fa parte del gruppo VIII, ma invece di essere nel blocco p come tutti gli altri elementi del gruppo VIII, si trova nel blocco s. Ricordi che il suo guscio esterno ha spazio solo per due elettroni? Questo perché il guscio contiene solo un sottoguscio s, mentre tutti gli altri elementi del gruppo VIII hanno anche un sottoguscio p. Ciò significa che l'elettrone di valenza a più alta energia dell'elio si trova in un guscio s, rendendolo un elemento del blocco s.
Per saperne di più sui sottogusci di elettroni, si veda Gusci di elettroni e configurazione degli elettroni.
 Figura 6. Blocchi nella tavola periodica.
Figura 6. Blocchi nella tavola periodica.
Metalli tavola periodica
L'ultimo modo di strutturare la tavola periodica che vedremo oggi prevede la suddivisione della tavola con una linea che parte da sinistra del boro e si snoda verso destra e verso il basso, insinuandosi tra il silicio e il germanio, poi tra l'arsenico e l'antimonio e tra il tellurio e il polonio. Infine, divide l'astatina dalla tennessina, prima di terminare a sinistra dell'oganesson.
Questa linea ha vari nomi: linea metallo-non metallo, linea anfotera, linea metalloide e scala. Essa divide la tavola in metalli, non metalli e metalloidi.
- Gli elementi a sinistra della linea sono classificati come metalli.
- Gli elementi a destra della linea (oltre all'idrogeno) sono classificati come non metalli.
- Alcuni degli elementi che toccano la linea sono classificati come metalloidi.
 Figura 7. Metalli, non metalli, metalloidi.
Figura 7. Metalli, non metalli, metalloidi.
Metalli
I metalli si trovano sul lato sinistro della tavola periodica. Hanno alcune proprietà caratteristiche.
- I metalli perdono tipicamente elettroni per formare cationi positivi.
- Hanno punti di fusione e di ebollizione elevati.
- Hanno bassi valori di elettronegatività.Hanno un aspetto lucido e brillante quando sono appena tagliati.
- Sono malleabili e duttili.
- Sono buoni conduttori di calore ed elettricità.
Non-metalli
I non metalli si trovano sul lato destro della tavola periodica (ad eccezione dell'idrogeno, che è anch'esso un non metallo). Come suggerisce il nome, sono l'opposto dei metalli. In effetti, si può pensare che siano semplicemente privi di caratteristiche metalliche.
- I non metalli in genere guadagnano elettroni per formare anioni negativi.
- Hanno valori di elettronegatività elevati.
- Presentano una gamma di punti di fusione e di ebollizione. Alcuni, come il silicio, hanno punti di fusione estremamente elevati, mentre altri, come l'ossigeno, hanno punti di fusione bassi.
- I non metalli solidi sono fragili.
- Sono scarsi conduttori di calore ed elettricità.
Metalloidi
I metalloidi si trovano al centro della tavola periodica. Si trovano a cavallo della linea di demarcazione che divide i metalli dai non metalli e le loro proprietà sono a metà strada tra i due.
- In genere, i metalloidi sono lucidi e brillanti al taglio, ma sono fragili per natura.
- Hanno valori medi di elettronegatività.
- Sono conduttori medi di elettricità.
Non esiste una definizione scientifica fissa di metallo, non metallo e metalloide. Per questo motivo, fonti diverse possono classificare alcuni elementi in modo diverso e, di fatto, alcuni scienziati tracciano la linea di demarcazione in un punto diverso. Ad esempio, il carbonio e il selenio sono talvolta riconosciuti come metalloidi.
Ora sappiamo com'è fatta la tavola periodica e come è strutturata. Ma come si è arrivati a questa struttura?
Storia della tavola periodica
All'inizio dell'articolo abbiamo paragonato la creazione della prima versione della tavola periodica a un puzzle con metà dei pezzi mancanti e senza un'immagine che faccia da guida. Per i chimici degli anni precedenti al XIX secolo, questa era la sfida da affrontare. Concentriamoci su tre scienziati e sul loro contributo alla moderna tavola periodica.
Johann Wolfgang Döbereiner
Nel 1817, il fisico tedesco Johann Wolfgang Döbereiner fu il primo a tentare di classificare gli elementi. Notò che era possibile raggruppare alcuni elementi in gruppi di tre, chiamati triadi, e che gli elementi all'interno di una triade condividevano proprietà simili. In effetti, le proprietà del secondo elemento della triade si collocavano a metà strada tra quelle del primo e quelle del terzo. Per esempio, egli raggruppò il litio, il sodio e il potassio, tutti metalli che oggi conosciamo come appartenenti al Gruppo I.
John Newlands
Nel 1864, anche il chimico britannico John Newlands notò la somiglianza delle proprietà tra alcuni elementi. Vide che se si disponevano tutti gli elementi in una tabella in base alla massa atomica, le loro proprietà si ripetevano a intervalli regolari. Queste proprietà si ripetevano ogni otto elementi, dando origine al nome di "legge delle ottave".
Tuttavia, all'epoca erano stati scoperti solo una sessantina di elementi. Newlands pensò erroneamente che quelli fossero gli unici elementi esistenti. Non lasciò spazi vuoti per gli elementi non ancora scoperti, quindi la sua tabella non aveva senso dopo il calcio. Inoltre, a volte metteva due elementi nella stessa casella. In generale, le sue idee furono ridicolizzate dai suoi colleghi.
 Figure 8: La versione di Newlands della tavola periodica.
Figure 8: La versione di Newlands della tavola periodica.
Dmitri Mendeleev
Infine, nel 1869, il chimico russo Dmitri Mendeleev arrivò alla versione della tavola periodica che conosciamo oggi. Egli riprese l'idea di Newlands sulla legge delle ottave, ma lasciò degli spazi vuoti per gli elementi non ancora scoperti, prevedendo le loro proprietà in base al comportamento degli elementi che li circondano. Pur disponendo gli elementi per lo più in ordine di massa atomica, ne cambiò alcuni per adattarli meglio alla sua legge delle ottave.
Ad esempio, l'argon era molto più pesante del potassio, ma mettere il potassio prima dell'argon significava che il potassio, metallo altamente reattivo, si sarebbe trovato in un gruppo con gas non metallici non reattivi, mentre l'argon, non reattivo, si sarebbe trovato in un gruppo con metalli reattivi. La sua tavola fu gradualmente accettata quando furono scoperti nuovi elementi che corrispondevano alle sue proprietà previste. La questione della massa atomica fu risolta con la scoperta delle particelle subatomiche nel XX secolo e gli scienziati si resero conto che gli elementi dovevano essere ordinati in base al numero atomico e non alla massa.
 Figure 9: La versione di Mendeleev della tavola periodica, con gli spazi vuoti lasciati per gli elementi non scoperti
Figure 9: La versione di Mendeleev della tavola periodica, con gli spazi vuoti lasciati per gli elementi non scoperti
Tavola periodica - Punti chiave
- La tavola periodica è una rappresentazione degli elementi ordinati in base al loro numero atomico.
La tavola periodica è strutturata in righe, colonne e blocchi.
Una riga della tavola periodica è nota come periodo. I periodi presentano una periodicità, ossia mostrano tendenze nelle loro proprietà che si ripetono ad ogni riga. Il numero atomico aumenta man mano che si passa da un periodo all'altro della tavola periodica.
Una colonna della tavola periodica è nota come gruppo. Gli elementi dello stesso gruppo hanno lo stesso numero di elettroni di valenza e reagiscono in modo simile.
La tavola periodica è divisa in blocchi. I blocchi sono gruppi di elementi che hanno tutti l'elettrone di valenza a più alta energia nello stesso sottoguscio.
È inoltre possibile classificare gli elementi come metalli, non metalli e metalloidi. I metalli si trovano a sinistra della tavola periodica, mentre i non metalli si trovano a destra. I metalloidi si trovano tra i due elementi.
- Le versioni precedenti della tavola periodica ordinavano gli elementi in base alla massa atomica, non al numero atomico. La tavola periodica moderna come la conosciamo oggi è stata creata da Dmitri Mendeleev nel 1869.
Argomenti simili in Chimica
Argomenti correlati a Chimica inorganica