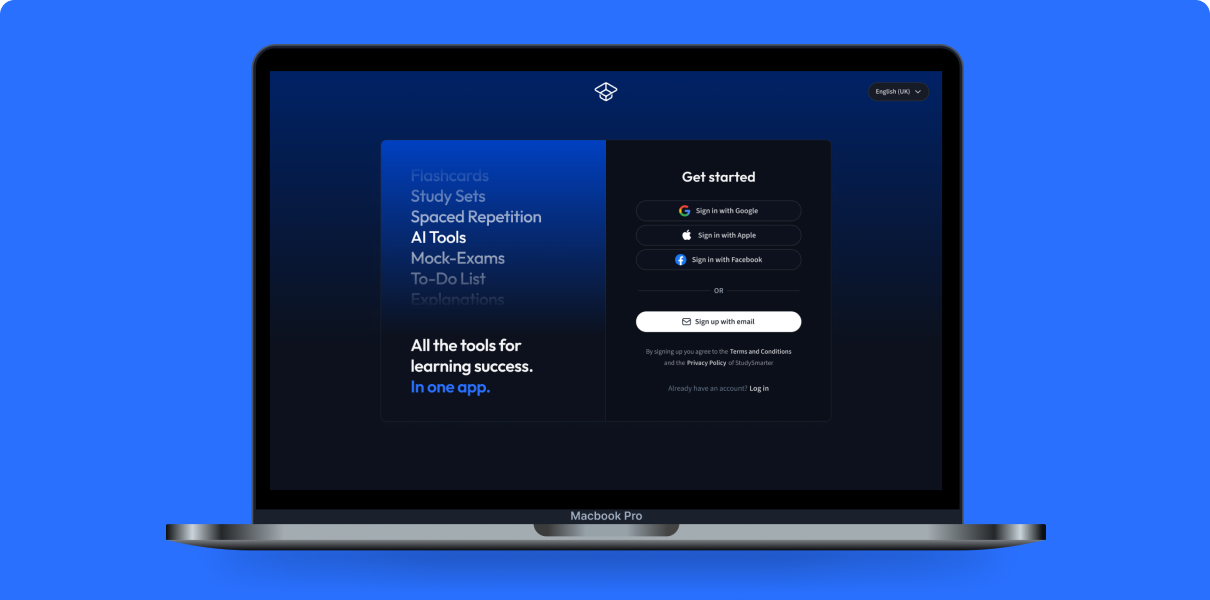- Questo articolo tratta delle ammidi in chimica organica.
- Inizieremo definendo le ammidi.
- Daremo un'occhiata al loro gruppo funzionale, alla formula generale e alla struttura.
- Scopriremo poi la nomenclatura delle ammidi.
- Successivamente, vedremo come si producono le ammidi prima di esplorare alcune delle loro reazioni.
- Infine, considereremo esempi e usi delle ammidi.
Che cosa sono le ammidi?
In chimica organica, potreste aver già incontrato le ammine. Si tratta di molecole organiche con il gruppo funzionale amminico, -NH2. Le ammidi sono molecole simili alle ammine. Contengono il gruppo amminico, -NH2, legato al gruppo carbonilico, C=O. Questo è noto come gruppo funzionale ammidico.
Le ammidi sono molecole organiche con il gruppo funzionale ammidico, -CONH2. Si tratta di un gruppo carbonilico legato ad un gruppo amminico.
Per maggiori informazioni su questi due gruppi funzionali, consultare le ammine e il gruppo carbonile.
Ammidi formula generale
Ora sappiamo che le ammidi contengono un gruppo carbonilico, C=O, legato a un gruppo amminico, -NH2. Questo dà alle ammidi la formula generale RCONH2. In questo caso, R rappresenta un gruppo organico unito all'altro lato del gruppo carbonilico.
La formula generale di un'ammide riportata sopra è in realtà la formula di un'ammide primaria. Si possono ottenere anche ammidi secondarie e terziarie, note anche come ammidi N-sostituite. In questi casi, uno o entrambi gli atomi di idrogeno attaccati all'atomo di azoto vengono sostituiti da altri gruppi organici R. Ciò conferisce alle ammidi secondarie e terziarie le formule generali RCONR'H e RCONR'R'', rispettivamente. Tuttavia, ci concentreremo soprattutto sulle ammidi primarie.
Struttura delle ammidi
Utilizziamo le nostre nuove conoscenze sulle ammidi per disegnarne la struttura. Ecco un esempio di ammide.
 Figura 1. Struttura generale di un ammide.
Figura 1. Struttura generale di un ammide.
Si noti il gruppo carbonilico a sinistra, con il suo doppio legame C=O, e il gruppo amminico a destra. Trattandosi di un'ammide primaria, l'atomo di azoto è legato a due atomi di idrogeno e a nessun altro gruppo R.
Polarità delle ammidi
Possiamo approfondire la struttura delle ammidi mostrando la loro polarità. Forse sapete che sia il gruppo carbonilico che quello amminico sono polari. Questo rende polari anche le ammidi. L'atomo di carbonio del gruppo carbonilico è sempre parzialmente carico positivamente, mentre l'atomo di ossigeno è parzialmente carico negativamente. Nel frattempo, l'atomo di azoto del gruppo amminico è parzialmente carico negativamente, mentre gli atomi di idrogeno sono parzialmente carichi positivamente.
 Figura 2. Un diagramma che mostra la polarità delle ammidi.
Figura 2. Un diagramma che mostra la polarità delle ammidi.
Nomenclatura delle ammidi
Andando avanti, diamo un'occhiata alla nomenclatura delle ammidi.
Ammidi primarie
La denominazione delle ammidi primarie è abbastanza semplice. Tutto dipende dal gruppo R collegato al gruppo carbonilico. In effetti, è molto simile alla denominazione degli acidi carbossilici.
Per dare un nome alle ammidi primarie, seguiamo la seguente procedura.
- Considerando l'atomo di carbonio del gruppo carbonilico come carbonio 1, trovare la lunghezza della catena di carbonio più lunga. In questo modo si ottiene il nome della molecola.
- Mostrare eventuali catene laterali o gruppi funzionali aggiuntivi utilizzando prefissi e numeri.
- Completare il tutto con il suffisso -amide.
Consideriamo un esempio.
Dai un nome alla seguente ammide:
 Figura 3. Un ammide incognita.
Figura 3. Un ammide incognita.
Applicando le regole di nomenclatura al nostro esempio precedente, possiamo vedere che la catena di carbonio più lunga è di tre atomi di carbonio. Questo gli conferisce il nome di radice -propan. Se numeriamo gli atomi di carbonio a partire dal carbonio del gruppo carbonilico, vediamo che al carbonio 2 è collegato un gruppo metilico. Questo ci dà il nome finale di 2-metilpropanammide.
 Figura 4. 2-metilpropanammide con atomi di carbonio numerati.
Figura 4. 2-metilpropanammide con atomi di carbonio numerati.
Ammidi secondarie e terziarie
Si ricorda che le ammidi secondarie e terziarie hanno gruppi R aggiuntivi attaccati all'atomo di azoto. Per indicare questi gruppi R, utilizziamo dei prefissi aggiuntivi, indicati con la lettera N-. Ecco un esempio.
Assegnare un nome alle seguente ammide:
 Figura 5. Ammide incognita.
Figura 5. Ammide incognita.
Ancora una volta, la catena di carbonio più lunga è di tre atomi di carbonio. Questo dà all'ammide il nome di radice -propan-. All'atomo di azoto è collegato anche un gruppo metile. Lo indichiamo con il prefisso metile, preceduto dalla lettera N-. Il nome di questa molecola è quindi N-metilpropanammide.
Produzione di ammidi
Passiamo quindi ad analizzare la produzione di ammidi. È necessario conoscere due reazioni simili:
- La reazione di addizione-eliminazione nucleofila tra un cloruro di acile e l'ammoniaca.
- La reazione di addizione-eliminazione nucleofila tra un cloruro di acile e un'ammina primaria.
Il meccanismo di queste due reazioni è approfondito in Acilazione.
Produzione di ammidi: cloruro acilico e ammoniaca
La reazione di un cloruro di acile con l'ammoniaca (NH3) produce un'ammide primaria e un cloruro di ammonio. Si tratta di una reazione di addizione-eliminazione nucleofila. È anche una reazione di condensazione, poiché rilascia una piccola molecola nel processo. In questo caso, la piccola molecola è l'acido cloridrico (HCl). L'acido cloridrico reagisce poi con un'altra molecola di ammoniaca per formare cloruro di ammonio (NH4Cl).
Ad esempio, facendo reagire il cloruro di etanoile (CH3COCl) con l'ammoniaca (NH3) si ottiene l'etanammide (CH3CONH2) e l'acido cloridrico, che reagisce ulteriormente con un'altra molecola di ammoniaca per formare il cloruro di ammonio (NH4Cl).
 Figura 6. Diagramma che mostra la reazione tra cloruro di etanoile e ammoniaca per produrre etanammine e cloruro di ammonio.
Figura 6. Diagramma che mostra la reazione tra cloruro di etanoile e ammoniaca per produrre etanammine e cloruro di ammonio.
Produzione di ammidi: cloruro di acile e ammina primaria
La reazione di un cloruro di acile con un'ammina primaria produce un'ammide secondaria, nota anche come ammide N-sostituita. Anche in questo caso si tratta di un esempio di reazione di addizione-eliminazione nucleofila. Si tratta anche di una reazione di condensazione, che libera acido cloridrico nel processo. L'acido cloridrico reagisce con un'altra molecola di ammina primaria per formare un sale di ammonio.
Ad esempio, facendo reagire il cloruro di etanoile (CH3COCl) con la metilammina (CH3NH2) si ottiene la N-metiletanammide (CH3CONHCH3) e il cloruro di metilammonio (CH3NH3Cl):
 Figura 7. Diagramma che mostra la reazione tra il cloruro di etanoile e la metilammina che produce N-metiletanammide e cloruro di metilammonio.
Figura 7. Diagramma che mostra la reazione tra il cloruro di etanoile e la metilammina che produce N-metiletanammide e cloruro di metilammonio.
Allo stesso modo, facendo reagire un cloruro di acile con un'ammina terziaria si ottiene un'ammide con due sostituenti N.
È possibile produrre ammidi anche attraverso la reazione tra un acido carbossilico e l'ammoniaca o un'ammina. Si fa prima reagire l'acido carbossilico con il carbonato di ammonio solido per produrre un sale di ammonio. Questo si trasforma in un'ammide quando viene riscaldato. Tuttavia, questo metodo presenta diversi svantaggi. È molto più lento della reazione tra un cloruro di acile e l'ammoniaca o un'ammina e non arriva al completamento. Ciò comporta una resa inferiore.
Reazioni delle ammidi
Ti stai chiedendo come reagiscono le ammidi? Esploriamo questo aspetto. È necessario conoscere due diverse reazioni:
- Idrolisi con un acido acquoso o alcali.
- Riduzione con LiAlH4.
Parleremo anche della basicità delle ammidi.
Reazioni di ammidi: idrolisi con acido acquoso o alcali
Per prima cosa, vediamo cosa succede quando si fa reagire un'ammide con un acido acquoso o un alcali. Si ottiene un acido carbossilico e ammoniaca o ammina, a seconda che l'ammide sia primaria, secondaria o terziaria. Si tratta di una reazione di idrolisi e richiede il riscaldamento. L'acido o l'alcali reagiscono poi con i prodotti formati.
- Se si utilizza un acido, questo reagisce con l'ammoniaca o l'ammina formata per produrre un sale di ammonio.
- Se si utilizza un alcali, questo reagisce con l'acido carbossilico formato per produrre un sale carbossilato.
Ecco un paio di esempi. Riscaldando l'etanammide (CH3CONH2) con acido cloridrico (HCl) acquoso si ottiene acido etanoico (CH3COOH) e ammoniaca (NH3), che reagisce ulteriormente per formare cloruro di ammonio (NH4Cl):
 Figura 8. Un digramma che mostra la reazione tra etanammide, acqua e acido cloridrico che produce acido etanoico e cloruro di ammonio.
Figura 8. Un digramma che mostra la reazione tra etanammide, acqua e acido cloridrico che produce acido etanoico e cloruro di ammonio.
L'acido cloridrico funge da catalizzatore nella prima parte della reazione, poiché non viene modificato o consumato nella reazione. Tuttavia, è coinvolto nella seconda parte della reazione, quando trasforma l'ammoniaca in cloruro di ammonio.
Il riscaldamento dell'etanammide con idrossido di sodio (NaOH) acquoso produce anche acido etanoico e ammoniaca. L'acido etanoico reagisce ulteriormente per formare etanoato di sodio (CH3COONa):
 Figura 9. Un diagramma che mostra la reazione tra etanammide e idrossido di sodio per produrre etanoato di sodio e ammoniaca.
Figura 9. Un diagramma che mostra la reazione tra etanammide e idrossido di sodio per produrre etanoato di sodio e ammoniaca.
In questo caso, l'ammide reagisce direttamente con l'alcali. Ciò significa che, a differenza della reazione con l'acido vista in precedenza, l'alcali è un reagente, non un catalizzatore.
È possibile utilizzare la reazione tra un'ammide e un alcali per verificare la presenza di ammidi. Il riscaldamento di un'ammide con l'idrossido di sodio produce ammoniaca gassosa, che fa diventare blu la cartina tornasole rossa. È anche riconoscibile per il suo odore pungente.
Reazioni di ammidi: riduzione con LiAlH4
Consideriamo poi cosa succede quando si riduce un'ammide utilizzando un forte agente riducente come il tetraidridoalluminato di litio, LiAlH4. La reazione elimina l'atomo di ossigeno del gruppo carbonilico dell'ammide e lo sostituisce con due atomi di idrogeno. Questa reazione avviene a temperatura ambiente in etere secco e produce anche acqua.
Ad esempio, la riduzione della metanammide (HCONH2) con LiAlH4 produce metilammina (CH3NH2) e acqua:
 Figura 10. Reazione tra una metanammide e un agente riducente per produrre metilammina e acqua.
Figura 10. Reazione tra una metanammide e un agente riducente per produrre metilammina e acqua.
Reazioni delle ammidi: basicità
Forse sai che le ammine agiscono come basi deboli. Questo perché l'atomo di azoto del gruppo amminico è in grado di raccogliere uno ione idrogeno dalla soluzione utilizzando la sua coppia di elettroni solitari. Tuttavia, nonostante contengano un gruppo amminico, le ammidi non sono basiche. Questo perché contengono un gruppo carbonilico, C=O. Il gruppo carbonilico è estremamente elettronegativo e attira la densità di elettroni verso di sé, riducendo la forza attrattiva della coppia di elettroni solitari dell'azoto. Pertanto, le ammidi non agiscono come basi.
Esempi ed utilizzi delle ammidi
Sapere cosa sono le ammidi e come reagiscono va benissimo, ma come si applica alla vita reale? Ecco alcuni esempi di ammidi e i loro usi.
- Le proteine, dalla cheratina dei capelli e delle unghie agli enzimi che catalizzano le reazioni cellulari, sono tutte poliammidi. Sono costituite da molte unità monomeriche più piccole, chiamate aminoacidi, unite tra loro da gruppi di legami ammidici.
- Anche le plastiche e le fibre sintetiche, come il nylon e il kevlar, sono tipi di poliammidi. Lo sono anche le fibre naturali come la seta e la lana.
- Hanno un ruolo nell'industria farmaceutica: il paracetamolo, la penicillina e l'LSD sono tutti esempi di ammidi.
- Anche la molecola organica urea, un prodotto di scarto naturale che espelliamo con l'urina, è un'ammide. Viene prodotta a livello industriale per essere utilizzata nei fertilizzanti e nei mangimi.
Dovreste essere in grado di definire le ammidi e di fornire la loro formula generale e la loro struttura. Dovreste essere in grado di descrivere come si formano e come reagiscono. Infine, dovreste essere in grado di nominare alcuni esempi comuni di ammidi.
Ammidi - Punti chiave
- Le ammidi sono molecole organiche con il gruppo funzionale ammidico. Questo consiste in un gruppo carbonilico (C=O) legato a un gruppo amminico (-NH2).
- Le ammidi possono essere primarie, secondarie o terziarie. Le ammidi secondarie e terziarie sono chiamate ammidi N-sostituite.
- Le ammidi sono denominate con il suffisso -ammide.
- Le ammidi si formano nella reazione tra un cloruro di acile e l'ammoniaca o un'ammina primaria.
- Le ammidi reagiscono con un acido acquoso per formare un acido carbossilico e un sale di ammonio, e con un alcali acquoso per formare un sale di carbossilato e ammoniaca.
- Le ammidi possono essere disidratate con LiAlH4 per ottenere un'ammina e acqua.
- Esempi comuni di ammidi, includono proteine, paracetamolo e nylon.

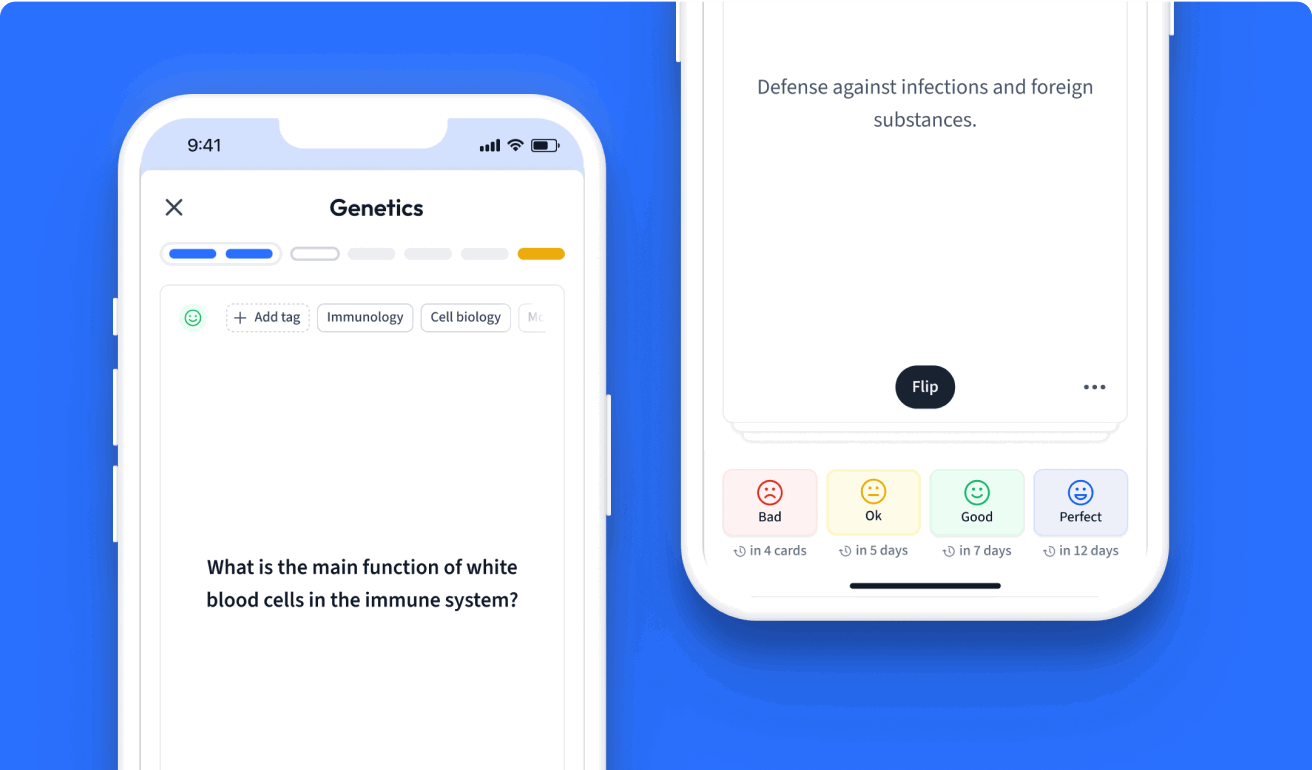
Learn with 17 Ammidi flashcards in the free StudySmarter app
We have 14,000 flashcards about Dynamic Landscapes.
Hai già un account? Accedi
Domande frequenti riguardo Ammidi
Dove si trovano le ammidi?
Le ammidi si possono trovare in diversi prodotti, dai farmaci come il paracetamolo al nylon o nelle proteine a livello muscolare.
Come riconoscere un'ammide?
Le ammidi sono molecole organiche con il gruppo funzionale ammidico, -CONH2. Si tratta di un gruppo carbonilico legato a un gruppo amminico.
Come si ottiene un'ammide?
La produzione di ammidi può avvenire considerando le seguenti reazioni:
- La reazione di addizione-eliminazione nucleofila tra un cloruro di acile e l'ammoniaca.
- La reazione di addizione-eliminazione nucleofila tra un cloruro di acile e un'ammina primaria.
Perché le ammidi sono neutre?
Perchè il doppietto elettronico dell'azoto è poco disponibile a legare un protone perchè è delocalizzato.
Che reazioni danno le ammine?
Le ammine danno reazioni di idrolisi o riduzione.
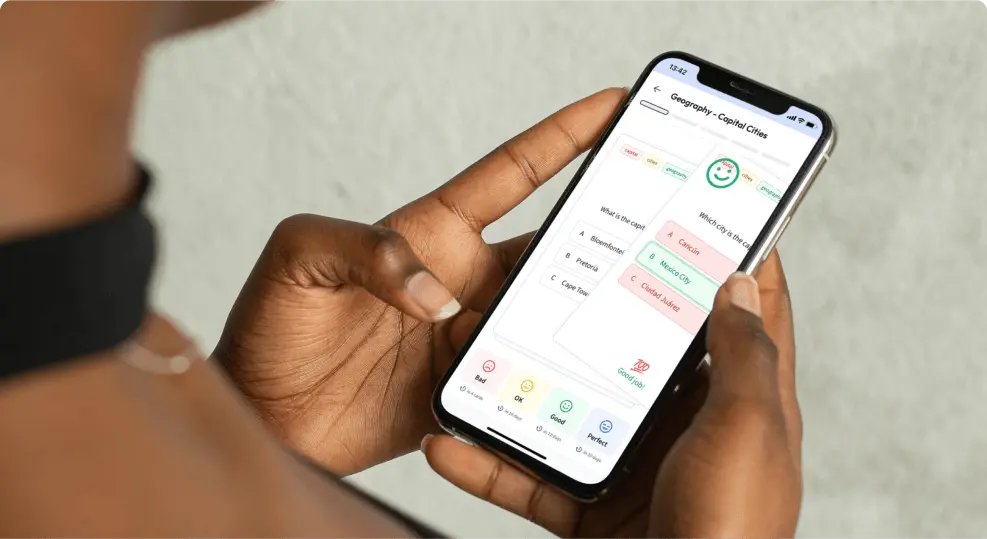
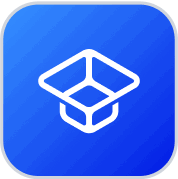
About StudySmarter
StudySmarter is a globally recognized educational technology company, offering a holistic learning platform designed for students of all ages and educational levels. Our platform provides learning support for a wide range of subjects, including STEM, Social Sciences, and Languages and also helps students to successfully master various tests and exams worldwide, such as GCSE, A Level, SAT, ACT, Abitur, and more. We offer an extensive library of learning materials, including interactive flashcards, comprehensive textbook solutions, and detailed explanations. The cutting-edge technology and tools we provide help students create their own learning materials. StudySmarter’s content is not only expert-verified but also regularly updated to ensure accuracy and relevance.
Learn more